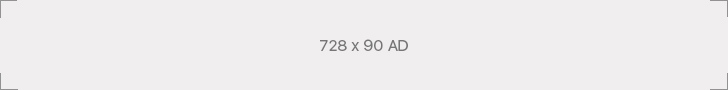di Ezio Mauro
Un giornale può sentirsi orfano, quando muore il padre. Esce ogni giorno, ogni giorno cambia, scritto com’è quotidianamente dalla realtà mutevole e sorprendente dei fatti. Però un giornale ha un’anima, un carattere, una sua natura particolare capace – se rispettata – di rendere il tutto coerente e di tenerlo insieme, firme e lettori, generazioni diverse, storie e provenienze: giorno dopo giorno, un anno dopo l’altro. L’anima di Repubblica è la vera creatura di Eugenio Scalfari, fatta a sua immagine e somiglianza ma con un dono speciale, quello della libertà nella conoscenza e nelle scelte. Perché il vero fondatore è chi crea qualcosa e poi lo lascia andare in un cammino autonomo, fedele nella libertà, perché gli possa sopravvivere.
C’è la fierezza per ciò che ha costruito, la commozione per averlo perduto, e il senso dell’abbandono nell’ultimo saluto a Eugenio, oggi. Si scoprono i sentimenti di un giornale, il vuoto e il dolore nella redazione, il lutto attorno a noi, tra i lettori, nelle istituzioni, nella società. Scalfari costituiva un mondo, lo definiva, lo rappresentava. Per noi era molto di più, il punto d’inizio e il punto di riferimento, il creatore di una comunità che si è scelta e deve continuare a scegliersi ogni giorno, una voce, un consiglio, un’amicizia e un affetto. Noi non abbiamo soltanto lavorato con lui: gli abbiamo voluto bene, come si fa con un progenitore che c’è sempre stato, con cui hai condiviso le vittorie e le sconfitte, e su cui pensavi di contare per sempre.

La verità è che non ci ha preparati al distacco, nonostante una vita lunga un secolo. Non i lettori, che lo hanno trovato qui ogni domenica dal 1976 fino alle ultime settimane, ma nemmeno noi, i suoi compagni. La forza intellettuale, la vivacità politica, la curiosità delle cose grandi e piccole rimanevano intatte, ci interpellavano ogni giorno e più volte al giorno e riscattavano il fisico infragilito, il movimento più lento, una fatica crescente nel muoversi. Fin che ha potuto entrava qui, ogni mattina, con quella sua eleganza distratta, fortemente personale, il bastone che sembrava un vezzo più che un appoggio. I gesti sempre uguali mentre sedeva, poi accavallava le gambe e subito accendeva una sigaretta, anche se negli uffici non si può più fumare.
A quell’ora del mattino, prima della riunione di redazione, aveva letto soltanto Repubblica, tutta. Bastava perché il mondo gli girasse intorno nelle sue orbite conosciute, e lui si sentisse capace di comprenderlo. Scherzava, si appassionava, raccontava sceneggiandolo un episodio della cena con gli amici la sera prima, si fermava su un pettegolezzo, ragionava sulla politica. Ogni tanto un accenno al tramonto, un pensiero sulla fine. Soltanto l’età era ormai un punto fisso dei discorsi, prima una scusa per dire di no a qualche appuntamento e non viaggiare, poi in qualche raro caso quasi una confessione, come una verità da condividere in silenzio, insieme, commuovendosi quando nominava Enrica e Donata e parlava di Simone, il nipote.Il giornale, la sua gente, continuava a vivergli attorno, come a un vecchio padre da cui si parte e a cui si torna. Lo guardavamo mentre parlava in piedi con l’amico di un’intera vita, Carlo Caracciolo, o con il compagno di tanti anni, Carlo De Benedetti, infine con John Elkann, l’editore di quel mondo torinese a cui pure era legato attraverso la famiglia: e sapevamo che nelle mani, o forse in tasca, o nella mente e nel cuore lui teneva comunque sempre quella scintilla immateriale che trasforma un’impresa in un’avventura collettiva, una redazione in un giornale, un quotidiano in un soggetto che parla al Paese e non soltanto del Paese.
Dentro la creazione della sua maturità – Repubblica appunto – confluivano le sue diverse vite e i mondi che aveva frequentato: la gioventù immersa negli anni del fascismo, il liceo delle grandi amicizie, la provincia e le capitali, il francese come scuola culturale, Milano e le domeniche mattina nell’ufficio di Mattioli, la genesi liberale, l’esperienza radicale e l’incontro definitivo con la sinistra italiana, gli anni dell’Espresso che costruivano un mondo e non soltanto un giornale, e infine l’ambizione di Repubblica.
Più tante altre cose, alcune delle quali segrete, o almeno intime: sentimentali.
Da qualche parte sicuramente il mare, una specie di paesaggio dell’anima davanti al quale andava a passeggiare la sera con la madre, ai bagni Pirgus, quel mare che il nonno dipingeva nei suoi quadri e che lui “sentiva” da bambino affacciato al balcone della sala, guidato mentre scendeva il buio dalle prime luci delle lampare, dalle sirene dei vaporetti rimorchiatori che rientravano in porto, dalle cabine illuminate giù al largo. Una presenza costante come un rumore di fondo e un elemento della sfida. Che per Eugenio comincia da bambino, quando si assegna la responsabilità adulta di tener uniti i genitori in un matrimonio che scricchiola nella casa di Civitavecchia: una prova che poi prenderà il largo con il mito di Ulisse sempre frequentato, cercando la coscienza del limite, la conoscenza che lo supera, l’esperienza libertina che vuole provare il canto delle sirene, la responsabilità che fa tappare di cera le orecchie dei compagni, perché si salvino.
Più libri più liberi, Eugenio Scalfari: storia di un grande giornalista
Qui c’è tutta la sfida riassunta in una parola: la conoscenza. Non solo una prova, dunque, o un cimento, un duello con un avversario. La vera sfida è il superamento di una soglia insieme e per conto dei compagni d’avventura, ed è soprattutto una partita con se stessi. Mettersi continuamente in discussione, puntare ogni volta ad un orizzonte più ampio, ripartire per un nuovo viaggio dopo ogni conquista.Il giornale è questa necessità, e quest’occasione. Soprattutto per chi lo fonda e con questa fondazione fissa un’identità, disegna un profilo, indica un percorso di evoluzione e di crescita. Nel giornale di Eugenio, così come lui lo ha concepito, c’è la sfida di una comunità intellettuale e d’impresa, il miracolo di un incrocio vivo di generazioni diverse, di esperienze disparate, di provenienze differenti unite in una cultura di riferimento – con lui la chiamavamo una certa idea dell’Italia – e un obiettivo comune. Non è l’atto di governo quotidiano che unifica e tiene tutto insieme, bensì l’atto di nascita, l’imprinting, il dna. E solo il fondatore ha – per sempre – la dimensione della paternità, del soffio iniziale, di chi ha visto la barca prendere il largo con un equipaggio che lui ha scelto, su un legno che lui ha intagliato, verso una rotta che lui conosce. Non per caso quando non lo conoscevo personalmente, Scalfari mi ricordava un Gulliver che leggevo da bambino, disegnato mentre tirava dietro di sé con le mani i fili delle navi di Lilliput.
Il risultato è una concezione del giornale che va ben al di là della fotografia della giornata per puntare alla ricostruzione del mondo, all’invenzione del contesto, all’intelligenza degli avvenimenti, alla comprensione dei fenomeni. Cioè la creazione di una vera e propria macchina della conoscenza: capace di aiutare il lettore a partecipare e a capire, dunque a diventare un cittadino consapevole, proprio perché informato. Con un punto di vista forte, dichiarato e trasparente, perché non è una scelta partitica ma un’identità culturale, un modo di essere e di guardare al Paese e al mondo.
Se dovessi riassumere l’avventura giornalistica di Eugenio, direi che è la scommessa del cambiamento, anche in questo Paese, nonostante tutto, credendo ostinatamente che sia possibile persino in Italia. Crederlo, e testimoniarlo, appoggiandosi a due culture di minoranza, unite in quello che con disprezzo gli avversari chiamano ancora azionismo e che noi teniamo a cuore: la pratica politica della sinistra coniugata con il metodo liberale. Una scommessa, certo, anche un azzardo: puntare su un’Italia che non c’è, ma che si può costruire rifiutando la rassegnazione, partendo dal fondamento culturale delle cose, credendo nel valore di un impegno civile, nel sentimento costituzionale, di libertà, repubblicano. Nella felicità possibile della democrazia.
Questa sfida è più credibile se nasce dalla capacità di cambiare se stessi, mentre si chiede il cambiamento. E Scalfari ha rivoluzionato il modo di essere del giornale italiano, nel 1976, e attraverso la novità di Repubblica ha cambiato il giornalismo. Basta pensare al formato, che oggi tutti hanno adottato ma che allora sembrò e fu rivoluzionario, alla fine della terza pagina accademica, al paginone centrale per la cultura, alle pagine due e tre dedicate al fatto del giorno: tutte rivoluzioni diventate oggi patrimonio comune, ma nate dal suo genio giornalistico e dalla sua Repubblica, che da lui ha ricevuto la magnifica condanna dell’innovazione permanente. Con la scuola del grande settimanale unita al quotidiano Scalfari ha insegnato a non accontentarsi mai della dimensione frontale delle vicende, ma a inclinare ogni fatto e ogni giornata sul suo lato critico, cercando quel deposito di significato riposto che sta sul fondo delle cose.

Questa ricerca scalfariana di senso è ciò che trasforma l’informazione in conoscenza, la conoscenza in coscienza, il lettore in cittadino. E Repubblica in un unicum che non si può omologare, molto meno di un partito – come pigramente dicevano gli avversari – ma qualcosa più di un giornale, nella forza della sua soggettività e dell’identificazione con i lettori. Il quotidiano pensato da Eugenio è parte della vita del Paese, non della sua rappresentazione: e a differenza del cinema e della letteratura il suo giornalismo non è una struttura mimetica ma svela chi lo fa, porta in primo piano le sue idee e le sue passioni. Perché Scalfari è stato soprattutto un giornalista di idee, capace di cercare in ogni vicenda la dimensione culturale delle cose, quella che rivela perché dà sostanza, quella che resta perché è qualcosa che vale, dunque che dura. Per questo penso al dialogo quotidiano con Eugenio anche come a un antidoto al sentimento dell’effimero che pesa inevitabilmente sulla vita di un giornale, qualcosa che va oltre l’amicizia e l’affetto personale, oltre il dolore e la mancanza, perché lega le radici alle foglie come solo lui poteva fare.Di questo, e di molto altro, ho fatto in tempo a ringraziarlo, con parole che sono soltanto nostre. In pubblico, lo abbraccio ancora una volta come abbiamo fatto ad ogni incontro, senza falsi pudori, e gli dico grazie per ciò che ha lasciato a tutti noi. So che ognuno degli uomini e delle donne di questa redazione e di quest’azienda porta con sé un “segno” dell’incontro con Scalfari, un gesto di attenzione individuale, un tono particolare del rapporto, un ricordo privato. Ma c’è qualcosa che vale per noi tutti: lo chiamerei l’algebra e il fuoco, la buona grammatica delle cose e la passione culturale che le attraversa e le illumina di senso. Una passione scalfariana che facciamo nostra per fedeltà e per scelta, nella ricerca comune di quello che con Eugenio, citando Williams, chiamavamo «lo strano fosforo della vita»: che poi è la materia del suo giornalismo e della sua amicizia, della sua natura. È il lascito che lui vorrebbe, quello che salutandolo oggi scegliamo e che porteremo con noi, riconoscendolo gli uni negli altri, dovunque saremo.